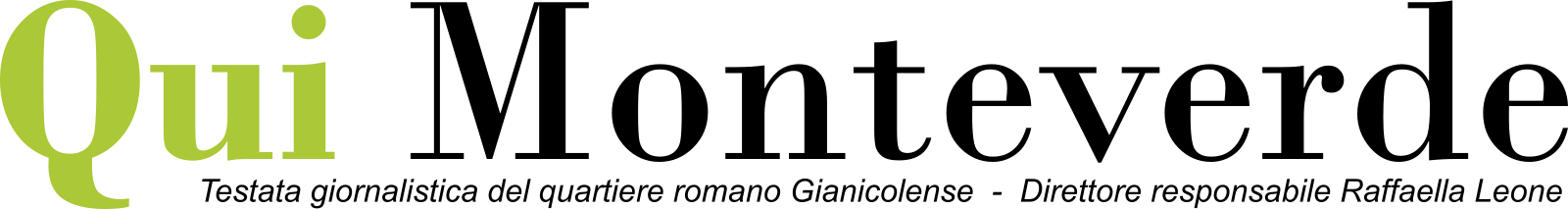L’Ucraina nella UE? Un problema di “Europa”
da RETIDIPACE un articolo di FrancescaLacaita

Un articolo dotto e estremamente interessante che mette in luce come l’attuale Unione Europea – di fatto belligerante – mini profondamente il progetto iniziale dell’Unione Europea, storicamente un progetto di Pace.
L’autrice sviluppa un percorso dettagliato, argomentato in modo stringente, su questa metamorfosi.
transform! italia

Le contraddizioni di un’Unione Europea di fatto co-belligerante minano lo stesso progetto europeo che si vorrebbe difendere –
Scriveva Alexander Langer nel 1995, poco prima di morire, nel suo giustamente celebre L’Europa muore o rinasce a Sarajevo:
La politica di pace più efficace è oggi l’offerta di integrazione: più che qualunque altra proposta o piano di pace, funziona il semplice invito “vieni con noi, unitevi a noi”. La smania degli europei dell’est di entrare a far parte della NATO, si spiega facilmente come ricerca di sicurezza (e in fondo la NATO è riuscita a contenere contemporaneamente greci e turchi!). Se si vuole promuovere pace in una regione nella quale la precedente casa comune si è dissolta, l’offerta più credibile è quella di entrare sotto un tetto comune più ampio e meno condizionato dai rispettivi nemici preferiti. Ecco perché a tutti i paesi successori dell’ex Jugoslavia bisogna aprire le porte dell’Europa, a condizione che scelgano la convivenza, al posto dell’esclusivismo etnico, lo Stato democratico invece che etnico. (Naturalmente questa prospettiva implica che si lavori forte alla costruzione della casa comune europea, e che l’Unione europea come tale evolva rapidamente in tal senso).
Sono passati quasi trent’anni. Nel novembre 1995 furono siglati gli Accordi di Dayton, che posero fine alla guerra in Bosnia e determinarono l’assetto politico del paese. Un assetto che persiste ancora oggi, basato su una divisione etnica e settoriale, senza che si giungesse mai a una vera pace tra le diverse componenti etnonazionali. La massima autorità politica resta l’Alto Rappresentante per la Bosnia (dal 1° luglio del 2021 è i
il tedesco Christian Schmidt), finora sempre di nazionalità di paesi UE (mentre il suo vice è sempre stato uno statunitense), con i “pieni poteri” di attuare gli Accordi, e poiché la normalizzazione è comunque ancora di là da venire, il paese permane in una condizione di perpetua minorità. Riguardo all’adesione all’Unione Europea, la Bosnia ha firmato l’Accordo di Stabilizzazione e Associazione nel 2007, ha presentato domanda di adesione nel 2016, ha inviato le risposte al questionario della Commissione Europea nel marzo 2019, e la Commissione, nello stesso anno, ha elaborato un suo parere e pubblicato un elenco di 14 priorità fondamentali da soddisfare.
In una situazione analoga si trova il Kosovo. L’indipendenza dalla Serbia, dichiarata unilateralmente nel febbraio 2008, non è stata riconosciuta da tutti i paesi UE (non da Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia, Spagna); ciononostante, la stessa Commissione Europea non ha trovato ostacoli legali all’avvio dei negoziati sull’Accordo di Stabilizzazione e di Associazione, che è stato siglato tra le due parti nel luglio 2014 ed è entrato in vigore nel 2016. Nello stesso anno è pure entrato in vigore l’Accordo di Associazione UE-Moldavia.
Per quanto riguarda l’Ucraina, il processo di avvicinamento alla UE è stato certamente più drammatico, ma più accelerato. Com’è noto, fu il ritiro dell’allora presidente Janukovyč, dietro pressione di Mosca, dall’Accordo di Associazione, alla fine del 2013, a innescare la rivolta di “Euromaidan”, con tutto quel che ne conseguì. L’Accordo fu infine firmato nel 2014, ed è entrato in vigore nel 2017. Non senza qualche brivido, come quando la sua ratifica fu respinta da un referendum consultivo tenutosi nei Paesi Bassi nell’aprile 2016 – inghippo superato dalla dichiarazione del Consiglio Europeo che comunque l’Accordo di Associazione non impegnava la UE su questioni come l’elargizione di aiuti finanziari, l’assistenza militare, la libertà dei cittadini ucraini di risiedere e lavorare nel territorio UE, e l’adesione stessa dell’Ucraina alla UE. Con la guerra, le cose sono precipitate. Il presidente ucraino Zelensky ha presentato la richiesta di adesione; il Parlamento Europeo all’inizio di marzo ha votato a grandissima maggioranza una risoluzione che invita le istituzioni europee «ad adoperarsi per concedere all’Ucraina lo status di paese candidato all’adesione all’UE». Il paese ha già compilato e consegnato il fatidico questionario, nello stesso periodo è stato inviato quello della Moldavia e la prima parte di quello della Georgia. La Commissione darà il proprio parere sull’adesione dell’Ucraina a giugno, in tempi eccezionalmente rapidi. Tuttavia il percorso per raggiungere lo status di membro a tutti gli effetti è ancora lungo, e tutto in salita.
Certo, occorre considerare se la disgrazia di un’aggressione consente di saltare una fila che vede non solo Georgia, Moldavia, Bosnia e Kosovo, ma anche i paesi ufficialmente candidati, la Turchia, la Macedonia del Nord, il Montenegro, la Serbia e l’Albania. Occorre ancora pensare a come integrare in tempi brevi il secondo paese più povero d’Europa (il primo è la Moldavia) in una UE che con la politica di associazione ha scelto di perseguire la sua espansione proteggendosi, tramite una cintura di “stati cuscinetto”, dai mali del mondo post-1989. Ma ci sono altri aspetti che certamente pesano, e che preoccupano pure gli “interventisti democratici”, anche se pare brutto menzionarli quando il paese è impegnato in una guerra di difesa: dalla corruzione diffusa alle fragilità della democrazia e dello stato di diritto (a cominciare dalla messa al bando dei partiti all’opposizione), dai diritti delle minoranze nazionali al peso e all’influenza delle formazioni neonaziste o militari di estrema destra nella società e nello stato. Per non dire di quegli europeisti a cui capita talvolta di ringhiare, a proposito di questa o quella manifestazione di “nazionalismo” da parte di qualche politico dell’ex Europa orientale, “non dovevamo farli entrare” (nella UE): c’è ancora un abisso tra la rivendicazione della sovranità e dell’autodeterminazione dell’Ucraina, che i governi europei sostengono con l’invio delle armi (in quanto, si dice, non ci sarebbe altro modo di sostenerla) e l’atteggiamento doverosamente remissivo che ci si aspetta abbia un neoarrivato nel consesso europeo, specie se tale neoarrivato avrà bisogno dell’aiuto materiale degli altri paesi per riprendersi dalle devastazioni della guerra.
Sullo sfondo di queste considerazioni si profila la proposta di «un nuovo ordine europeo» presentata da Enrico Letta sul «Foglio» dell’11 e ribadita sul «Corriere» del 19 aprile, incentrata sulla creazione di una “Confederazione Europea”, affiancata alla UE, che dovrebbe comprendere gli attuali paesi della UE più i candidati ufficiali o potenziali all’adesione – quindi anche l’Ucraina, ma stranamente non la Turchia –con lo scopo di evitare gli errori del passato, quando si passò improvvisamente da 15 a 25 membri nella UE, e di creare allora uno spazio in cui perseguire il dialogo politico tra i 36 membri della Confederazione e «far coesistere due esigenze complementari: la condivisione immediata della politica e l’adeguamento progressivo delle politiche». Il momento centrale sarebbe costituito dal vertice dei leader dei 36 paesi, che «con forza simbolica, nello stesso luogo» seguirebbe immediatamente le riunioni del Consiglio Europeo.
La proposta di Letta è stata oggetto di critiche (tra l’altro, su «Transform Italia»), anche da parte di chi non è lontano dal segretario del PD. Esse vanno dalla creazione di un inutile doppione (dopotutto, non mancano le occasioni di incontro tra paesi candidati e paesi UE), alla svalutazione del Consiglio d’Europa, cui fanno parte tutti questi paesi; dal rischio che comporterebbe una maggiore prossimità politica a paesi non del tutto pacificati al proprio interno o con i propri vicini, alla probabilità di uno spostamento a Est del baricentro politico della Confederazione e della messa in minoranza dei paesi fondatori, se si dovesse introdurre, come propone Letta, il voto a maggioranza. In ogni caso, l’ipotesi lettiana, come pure alcune di queste obiezioni che le sono state mosse, non fa che ribadire quella politica della “sala d’attesa” verso i paesi dell’ex Europa orientale stigmatizzata a suo tempo da Alexander Langer, la preoccupazione di tenersi a debita distanza da determinati paesi e dai loro problemi, che la cosmesi e la retorica della «forza simbolica» dovrebbero in qualche modo occultare, le gerarchie tra l’“Ovest” e l’“Est”. Significativamente, la “Confederazione” non è pensata per altri paesi europei al di fuori della UE ma appartenenti all’Europa occidentale; non viene quindi contemplata la presenza di Regno Unito, o Svizzera, o Islanda, o Norvegia, che potrebbero aderire alla UE subito se lo volessero. L’«adeguamento progressivo delle politiche» riguarda ovviamente solo i paesi candidati, è inconcepibile che sia la UE a modificare le proprie per facilitare l’ingresso dei nuovi membri, così come è inconcepibile che le riunioni del Consiglio Europeo si tengano dopo il vertice dei leader della “Confederazione”, perché tocca comunque al primo dare la linea alla seconda. La «forza simbolica» di tutto ciò è senz’altro visibile e inequivocabile.
Quando Langer scriveva il suo appello per l’accoglienza nella UE dei paesi dell’ex Jugoslavia (suona strano e impossibile, ma in fondo, il progetto dell’unità europea non è storicamente stato innanzitutto un progetto di pace? E chi ha più bisogno di “Europa” di un paese in guerra?), era stato da poco firmato il Trattato di Maastricht. Ci si ricorderà come esso fosse allora decantato (o temuto) come la svolta che avrebbe fatto fare un enorme salto di qualità all’integrazione del continente, dato all’Europa un’unione politica, e addirittura costituito il preludio alla federazione europea (Langer era doverosamente scettico al riguardo). A distanza di trent’anni, con ancora una guerra che si combatte in Europa, e con ancora paesi – diversi dei quali direttamente coinvolti in conflitti – che chiedono di entrare nella UE e che si vuole tenere il più possibile a distanza, si può riflettere sul percorso che ci ha ri/portato qui. La guerra in Ucraina ha tolto tutti i veli e le foglie di fico che hanno ammantato per anni il discorso europeista mainstream.
Innanzitutto, l’Unione Europea si è rivelata essere un’unione economica, di mercato e poco più, in grande difficoltà a ripensarsi con altre funzioni, e in quest’occasione supinamente schiacciata sulla NATO. Finora solo Macron ha tentato di prendere l’iniziativa per un cessate il fuoco, ma essendosi mosso come presidente francese e non come UE, era ben difficile che conseguisse il risultato auspicato. L’Alto Rappresentante per gli affari esteri dell’Unione Europea, Josep Borrell, è stato da parte sua imbarazzante nella sua mancanza di idee e di ascolto, al di là del mantra di “più armi”. I guizzi di dubbio o di distinguo che si sono di tanto manifestati nei governi europei o nelle loro maggioranze (come in Germania e in Italia) sono rientrati o non hanno avuto seguito. Ciò contrasta impietosamente con le dinamiche che portarono negli anni Settanta alla Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e all’Atto finale di Helsinki del 1975. Vale la pena riconsiderarle, per misurare la distanza tra quanto si realizzò allora e il deserto di oggi: il ruolo dei paesi neutrali, a cominciare dalla Finlandia; il profilo autonomo dei nove paesi della CEE, quasi tutti loro peraltro anche membri della NATO, che seppero vincere le diffidenze e le resistenze degli Stati Uniti nei confronti di un’iniziativa che aveva origini in proposte sovietiche; lo sforzo di raggiungere un risultato a somma positiva, di conciliare visioni e principi contrapposti (come ad esempio il valore dei diritti umani e della libertà individuale da un lato e la sovranità statale dall’altro) per favorire il dialogo, l’accordo e il progresso; l’adozione del principio del consenso, essendo impossibile la votazione a maggioranza, che avrebbe solo certificato i contrasti; l’azione diplomatica e la mediazione non conflittuale. Dopo la caduta del muro di Berlino, la “Carta di Parigi per una nuova Europa”, del novembre 1990, annunciava quelli che avrebbero dovuto essere i nuovi rapporti tra Est e Ovest, nell’ambito della “casa comune europea”, per dirla con Gorbaciov. L’inizio recitava:
Noi, Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, siamo riuniti a Parigi in un periodo di profondi mutamenti e di attese storiche. L’era della contrapposizione e della divisione dell’Europa è terminata. Dichiariamo che per l’avvenire le nostre relazioni saranno basate sul rispetto e sulla cooperazione.
L’Europa si sta liberando dal retaggio del passato. Il coraggio di uomini e donne, la potenza della volontà dei popoli e la forza delle idee dell’Atto Finale di Helsinki hanno dischiuso una nuova era di democrazia, pace ed unità in Europa.
È questo il momento di realizzare le speranze e le aspettative nutrite dai nostri popoli per decenni: l’impegno costante per una democrazia basata sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali, la prosperità attraverso la libertà economica e la giustizia sociale nonché un’uguale sicurezza per tutti i nostri paesi.
I Dieci Principi dell’Atto Finale ci guideranno verso tale ambizioso futuro, così come hanno illuminato il nostro cammino verso migliori relazioni negli ultimi quindici anni. La piena attuazione di tutti gli impegni CSCE deve costituire la base per le iniziative che stiamo ora intraprendendo al fine di consentire alle nostre nazioni di vivere conformemente alle loro aspirazioni.
Purtroppo non è andata così. L’“Europa” è diventata tutta “Occidente” e ha accettato di sbiadirsi accanto agli USA proprio mentre annunciava con il Trattato di Maastricht il suo salto di qualità in senso “politico”. Ha assunto il punto di vista e la postura del vincitore della guerra fredda. Ha concepito cioè il mondo in termini di vincitori, che hanno tutte le ragioni, e di sconfitti, che hanno tutti i torti, e che possono solo riscattarsi con la sottomissione. Ha cancellato il ricordo di essere stata un continente diviso e degli sforzi fatti per venire a capo di tale divisione – chi sa più oggi del processo di Helsinki? Ha cancellato anche la memoria dei conflitti che hanno percorso la sua storia, attribuendo la persistenza o l’accendersi di focolai di conflitto a una carente europeità. Ha indicato ai paesi dell’ex Europa orientale la via per entrare nel club dei ricchi e dei vincitori, imponendo di “adattarsi” – prendere o lasciare – e dilazionando l’accesso a benefici essenziali della cittadinanza europea quali la libera circolazione delle persone e l’accesso allo spazio Schengen (da parte loro, i nuovi arrivati hanno raccolto i maggiori benefici integrandosi nel sistema economico a trazione tedesca, e si sono a modo loro difesi dalle pressioni del centro europeo appoggiandosi agli Stati Uniti e giocando la carta del “nazionalismo”, che trova consenso in chi non ritiene di aver ottenuto vantaggi dall’appartenenza alla UE). Ha confidato negli automatismi (del mercato, dei trattati, delle “riforme”, ecc.) per realizzare benessere e progresso, e non ha mai amato le discussioni bottom up su dove andare o cosa fare, tanto meno l’espressione dei conflitti sociali. Probabilmente anche le crisi di consenso che hanno investito l’Unione Europea negli ultimi decenni avrebbero potuto essere contenute, se ci fosse stata un’intesa sulla direzione da prendere e su cosa costruire insieme a chi per sue ragioni non intendeva seguire. Certo, bisognava fare politica, e non affidarsi agli automatismi. Occorreva pensare in termini di “casa comune europea”, e non in termini di “fortezza Europa”, in cui si rifugiano i meritevoli e gli altri sono lasciati fuori. Allora si sarebbe costruito un sistema di sicurezza comune, progettato innanzitutto per impedire le guerre, potenziando l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (che presso il suo Segretariato a Vienna ha un Centro per la Prevenzione dei Conflitti), o i Corpi Europei Civili di Pace, un’altra proposta di Alexander Langer, che sono stati effettivamente istituiti, ma che sembrano essere concepiti più in funzione del servizio civile per i giovani.
Invece, dopo il 1989 l’“Europa” ha condiviso il senso delle guerre che gli USA hanno condotto in giro per il mondo, senza che eventuali divisioni (come nel caso dell’attacco all’Iraq nel 2003) contrastassero in alcun modo il consenso di fondo. Quest’ultimo si è anzi cementato, dacché, sin dai tempi della prima guerra del Golfo nel 1990, tutto l’Occidente con i suoi alleati (la cosiddetta “comunità internazionale”) si è investito della missione di garantire la pace e gli equilibri del “nuovo ordine mondiale”, per quanto ammaccato. Si combattono ora “guerre giuste”, a difesa del diritto internazionale o dei diritti umani, in cui la demonizzazione dell’avversario, invariabilmente paragonato a Hitler, nega ogni legittimità alla ricerca della pace, che viene anzi intesa come ingenuità o connivenza con il nemico. L’unica conclusione possibile del conflitto è la vittoria totale e l’eliminazione dell’avversario. In particolare, la guerra della NATO contro la Serbia per il Kosovo, nella primavera del 1999, la “guerra umanitaria” per eccellenza, condotta in nome della difesa dei diritti umani oltre le frontiere e contro la sovranità statale, ha molto contribuito a “eticizzare” il conflitto militare, ad affermare, anche in “Europa”, la fede nel valore taumaturgico delle armi, più “veloci” ed “efficaci” del dialogo e del negoziato, nell’affermare la democrazia e i diritti umani. La guerra in Ucraina ha esacerbato tali tendenze, con effetti profondamente regressivi sul discorso pubblico. Nei media mainstream si sono condannati come giustificazioni implicite dell’aggressione russa ogni contestualizzazione, ogni richiamo alla complessità della situazione, ogni tentativo di capire. La censura di artisti, intellettuali, prodotti culturali russi nega proprio quell’incontro con l’Altro di nazionalità nemica in nome dell’antifascismo, o di altri ideali comuni, da cui nel Novecento è nata l’“Europa”.
Un’“Europa” che muore nel secolo successivo.